|
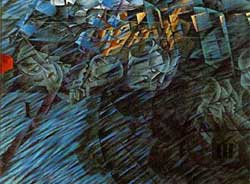
U. Boccioni, Quelli
che se ne vanno, 1911
|
Luisa Bonesio
L’ultimo guerriero e i combattimenti della tecnica
Prefazione a E. Jünger, Nelle tempeste
d’acciaio, tr. it. di G. Zampaglione, La Biblioteca di
“Libero”, Milano 2003.
|
Nelle tempeste d’acciaio
è il primo libro di Jünger, apparso nel 1920: è la
rielaborazione dei diari tenuti durante il servizio come volontario al
fronte nella prima guerra mondiale, nella quale si guadagnò numerose
ferite, sfiorò la morte, ottenne la croce di ferro, una medaglia
d’oro e la prestigiosa decorazione “Pour le mérite”, che lo consacrò
nel novero degli eroi nazionali, leggendario per il suo coraggio. Fu un
libro di straordinario successo, nell’immediato e lungo tutto il XX secolo,
tanto da oscurare ingiustamente, presso il largo pubblico ma anche presso
numerosi studiosi, la vastissima produzione dell’autore negli ottant’anni
successivi. Ed è stato il testo che è servito a costruire
l’icona di uno Jünger guerriero, militarista, spietatamente lucido
e portatore di una sorta di indifferenza morale, giustificando l’ammirazione
o la condanna in schieramenti ideologici opposti, immagine di fascino
estremo o emblema di valori detestabili. In realtà le cose sono
molto più sfumate e complesse, come si conviene con un grandissimo
del Novecento, anche per un libro scritto a soli venticinque anni.
Jünger annotava ogni sera, al fronte, gli eventi della giornata trascorsa
su libriccini tascabili, che portava con sé. Nelle lunghe pause
tra un’azione bellica e l’altra, leggeva. Durante l’ultima grande offensiva
del 1918, in cui fu gravemente ferito, nelle pause del fuoco gli teneva
compagnia il Tristram Shandy di Sterne. Molti
anni dopo, in un’intervista rilasciata al suo traduttore francese Julien
Hervier, il vecchio Jünger dirà: “C’erano, ad intervalli regolari,
della pause di una o due ore durante le quali leggevo Sterne; poi il fuoco
riprendeva, poi di nuovo Sterne; e, cosa strana, questa lettura si è
più profondamente impressa nella mia memoria di tutto il susseguirsi
dei combattimenti. Vale a dire che la letteratura è di fatto più
importante per me dell’esperienza vissuta, anche se concentrata all’estremo”.
Anche se divenne per alcuni anni del primo dopoguerra la figura di riferimento
dei circoli dei reduci e di un certo nazionalismo, egli abbandonò
molto presto e definitivamente l’identificazione con la figura del guerriero
di cui fu probabilmente l’ultima grande incarnazione, e lo scoppio del
secondo grande conflitto mondiale lo vedrà irreversibilmente cambiato,
ormai in grado di comprendere la vera natura della guerra alla luce della
sua interpretazione della modernità.
Eppure Nelle tempeste d’acciaio, fin dal
titolo, registra con gelida e veggente lucidità il cambiamento
intervenuto nell’epoca attraverso i modi di combattere la guerra: non
più combattimento in cui si esprimono il valore, il coraggio, l’abilità
dei soldati, ma battaglia di materiali, in
cui il ruolo determinante lo detengono le macchine, i dispositivi tecnici,
la potenza di fuoco, gli automatismi che, con la loro semplice esistenza,
decretano per sempre la fine del mondo dei valori aristocratici e guerrieri.
Una mitragliatrice ben piazzata si mostrava in grado di falciare interi
plotoni di uomini, vanificando il senso del coraggio e del valore; d’ora
in poi, protagonista delle guerre, sarebbe stata la tecnica con i suoi
micidiali ed esatti automatismi, con la sua oggettiva e devastante potenza.
“Fuoco e movimento” (che daranno il titolo a un saggio del 1930) sono
l’espressione di una logica cui il mondo non potrà più sottrarsi,
in una perenne “mobilitazione totale” che la tecnica attua incessantemente,
ben al di là delle occasioni di scontro conclamato. Nessuno, nemmeno
il bambino nella culla, può dirsi al riparo dallo smisurato potenziale
distruttivo della tecnica: come avrebbe dimostrato, sulla carne stessa
dell’Europa, il secondo conflitto mondiale, non solo la popolazione civile
si trova ad essere bersaglio di guerra, ma un’intera civiltà in
tutti i suoi aspetti.
La tecnica dunque opera sulla storia una cesura senza ritorno, che le
nuove modalità di combattimento meccanico mostrano in tutta la
loro terribile efficacia. Il giovane guerriero Jünger, che pure prodiga
il suo leggendario coraggio, con freddo disincanto registra – e dà
a vedere a un’intera epoca – la fine di un mondo e l’avvento di uno nuovo.
Non si tratta solo di materiali, di strategie: negli interminabili giorni
e nelle angosciose notti di noia, fango e topi delle trincee, nella velocità
delle azioni che non concede tempo alla pietà, nel fuoco e nell’acciaio
avanza una nuova epoca, che sorpassa nella sua realtà ogni più
sfrenata fantasia futuristica. In essa non c’è più spazio
per l’individuo nella sua irripetibile singolarità, con la sua
sfera di valori e propensioni; esso è sostituito da un nuovo tipo
d’uomo, cui sono richieste impersonalità, oggettività, prestazioni
che corrispondano all’esatta logica delle macchine con cui ha a che fare,
che scandiscono e organizzano il suo tempo e la sua esistenza, nel lavoro,
nel divertimento, nel sonno, nella malattia e nelle sue fantasie. Intercambiabile,
sempre più funzione degli apparati e della logica tecnica che “mette
al lavoro” tutto il mondo e la vita in ogni suo aspetto, questo nuovo
tipo di uomo, anonimo, funzionale, coniato uniformemente, fa la sua comparsa
nelle trincee e nel fango della prima guerra mondiale: soldato senza nome,
uguale a milioni di altri, addetto e servitore delle macchine di morte,
milite ignoto, il quale, una volta spogliata
l’uniforme da combattimento, assume quella da operaio
(che dà il titolo alla sua straordinaria opera del 1932), asservito
al nuovo e invincibile padrone del mondo: la ferrea logica di lavoro della
Tecnica.
La guerra non è che uno degli aspetti del lavoro tecnico: non più
eroi, ma operai e specialisti ne sono gli addetti, e la logica che si
sperimenta e si mette alla prova è quella di una potenza distruttiva
crescente, un titanismo e una smisuratezza dei mezzi e delle risorse,
in cui diventa sempre più difficile distinguere tra stato bellico
e condizione di pace, perché di fatto il mondo si trova in una
continua mobilitazione totale: delle sue energie, delle sue risorse terrestri
e umane, delle sue conoscenze, di ogni aspetto, anche il più celato,
della vita. Un enorme e sanguinoso dissodamento della Terra per l’affermazione
dell’impero tecnico, che darà luogo a quei “paesaggi da cantiere
e da officina”, in perenne trasformazione e dissesto, alla provvisorietà
informe e deforme della modernità, orizzonte di ghiaccio e di fuoco,
compresenza di esplosività tellurica, di fusione di materie e insieme
di freddezza e asetticità chirurgica delle procedure scientifiche
e degli apparati tecnici. Mondo di temperature roventi e di gelo disumano,
che Jünger anticiperà con tratti indimenticabili e in visioni
di straordinaria potenza, talvolta sfiorando accenti fantascientifici,
nelle opere degli anni ’30–’60. Ma già qui, giovanissimo eppure
con la impassibile lucidità che ne caratterizzerà sempre
lo sguardo, e insieme con la capacità di andare oltre la costrizione
che l’epoca esercita su di noi, Jünger, descrivendo gli effetti di
un bombardamento aereo su un carro armato, coglie la sostanziale terribilità
e il rischio catastrofico della potenza tecnica: “L’abitacolo, stretto
e fracassato dai proiettili, con il suo apparato di tubi, leve e fili
metallici, doveva essere stato molto oppressivo al momento dell’attacco,
quando quei colossi, per sfuggire all’artiglieria, se n’erano andati zigzagando
attraverso i campi simili a maldestri coleotteri giganti. Pensavo intensamente
agli uomini chiusi in quelle fornaci”.
pagine 1 - 2
Metropolis
© 2004-9 Geofilosofia.it - Tutti
i diritti riservati
|

